|
“Ad
locum cui Forinus nomen est” - La
battaglia di Forino del 663
Le battaglie
combattutesi a Forino che la storia ricorda perché decisive di
determinati eventi sono due: quella del 1799, tra i fedeli ai Borbone
ed i fautori della Repubblica Napoletana, e quella ben più
sanguinosa combattutasi tra le truppe Longobarde e Bizantine nel
663. Qui tratteremo di quest'ultima, decisiva per lo sviluppo
storico e sociale del nostro paese.
|
|
Nel 476, dopo numerose invasioni e migliaia di
battaglie cade l’Impero Romano d’Occidente. E’ la fine di un
millennio di storia caratterizzato dalla nascita e dalla potenza di
Roma nel mondo allora conosciuto, ed è l’inizio di un periodo
oscuro dominato dal caos e dalla paura. Non è conosciuto il modo
in cui gli abitanti della terra di Forino attraversarono questo
momento buio della storia. E’ certo che la religione cristiana
era ancora lontana da una penetrazione completa tra il popolo. Fatto testimoniato da documenti rogati nel VII secolo nelle
nostre contrade, che recano al posto della croce dopo la firma,
e quindi simbolo di cristianità, un triangolo, testimoniando che
il paganesimo era ben lontano dall’essere abbandonato. Roma da
molto tempo aveva smesso di essere il centro dell’impero, in
quanto Costantino aveva spostato la capitale dello stesso nella
meno antica Bisanzio, ma collocata in un punto strategico per i
suoi interessi, e la ribattezzò Costantinopoli. Ed è da li che
qualche anno dopo, l’imperatore Giustiniano pensò che fosse
giunto il momento di restaurare i fasti dell’antico impero,
imbarcandosi in una serie di guerre di riconquista dei territori
che oramai da quasi un secolo erano in mano alle popolazioni
barbare, cominciando quella che fu definita la guerra
greco-gotica (535-553). Pensò quindi di inviare in Italia, nel
535, il suo generale Belisario, il quale intraprese la campagna
di riconquista dei territori in mano ai Goti. |
|
Questa guerra fu per l’Italia una rovina.
Belisario dopo le prime effimere vittorie, accusò varie
sconfitte, e quindi il territorio passò da un dominatore
all’altro senza soluzione di continuità. Il territorio di Abellinum fu tenuto da Belisario solo pochi
anni (536-539), per poi essere ripreso da Totila (543), che
distrusse tutte le opere di difesa in esso esistenti per
impedirne ai Bizantini la rioccupazione. Per i Goti fu facile
rioccupare il territorio, in quanto le popolazioni indigene,
stremate dal fiscalismo bizantino della prima occupazione, si
erano date a Totila che era riuscito ad avere il loro appoggio
ma che poi operò radicali distruzioni lasciando fortificate solo
Napoli e Cuma. Dopo quindici anni di lotte, Giustiniano si
convinse di richiamare Belisario che non aveva combinato granchè,
e inviò il generale Narsete. In soli due anni di campagna
questo generale riuscì ad annientare i Goti, e a riportare
quindi l’Italia nell’Impero. E fin dal 552, dopo che i Goti
riportarono una sconfitta ad opera delle truppe bizantine
sui monti Lattari
ebbe così inizio l’epoca della dominazione bizantina dell’Italia
meridionale. Un dato di fatto fu che Narsete e le sue
truppe sostarono per più di un anno (553) nella piana tra il
fiume Sarno e Montoro. Curiosità confermata dalla presenza
nel comune di Montoro Inferiore, e più precisamente nella
frazione di Piazza di Pandola, del toponimo Campo dei
Greci. I bizantini introdussero il culto della figura di
San Nicola di Myra tra le nostre genti, prova che erano
abituali frequentatori delle nostre zone. Per giungere nella
nostra valle, e soprattutto per poter controllare meglio il
territorio dove erano di stanza, era necessario raggiungere
quel colle che domina la valle dell’Irno e che controlla gli
accessi ad essa. E quel colle è
quello che oggi noi conosciamo come Colle San Nicola.
Divagando con l’immaginazione, ci pare di assistere alle
cavalcate dei drappelli bizantini per le valli circostanti
il loro accampamento. |

Colle di San Nicola |
|
|
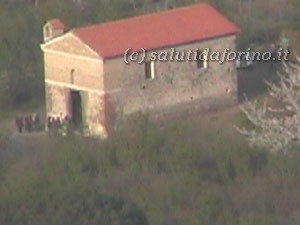
Chiesa di Santa Maria
Castro Forini |
Erano sicuramente attirati da quel piccolo monte
che dominava la valle di Montoro e che era un adatto punto
di osservazione per scrutare l’orizzonte e controllare il
nemico, che poteva coglierli in qualunque momento di
sorpresa. Ed è quindi in questo periodo, come ci narra la
tradizione orale ripresa dal primo estensore di una storia
di Forino, il padre Antonio Girolamo Tornatore, che nei
pressi del castello, posto sul colle a guardia della valle
di Montoro, si iniziò a venerare il Santo, “… la
cui rozza immagine, sospesa ad un albero, raccoglieva
intorno a se i pochi abitanti...”.
Inoltre, la tradizione vuole
che nell'area della contrada di Martignano, proprio dove
sorge la chiesa campestre di Santa Maria Castro Forini,
insistesse un accampamento bizantino, tesi che poteva essere
confermata da ritrovamenti archeologici di cui non si è
avuto modo di conoscerne l'esito. Si suppone, infatti, che
la chiesa possa sorgere su di un luogo di preghiera e
sepoltura. Il Tornatore scrive che vi erano abitanti. |
|
|
Potrebbe anche darsi che la
nostra valle, dopo aver ospitato insediamenti romani di varia
natura, abbia subito nel periodo “buio” di quegli anni uno
spopolamento, e che quindi, con l’arrivo dei bizantini, gruppi
di questi abbiano deciso di stanziarsi nella zona, visto che era
costume del tempo premiare i guerrieri più valorosi con
l’assegnazione di proprietà terriere da destinare all’uso
agricolo.
E certamente le nostre valli, oltre ad essere
comprese anticamente nel nemus corilianum, erano
sicuramente molto fertili per via delle ceneri vulcaniche che le
eruzioni del Vesuvio periodicamente avevano deposto, cosa
constatabile anche ai nostri giorni. Per la scomparsa di
Abellinum e per la peculiarità difensiva del bacino a
vantaggio di chi cercava scampo dalla pianura e dalla costa,
Forino entrò nell’orbita di Salerno. Venne cioè a far parte di
quell'area gravitante sulla città che visse per lungo tempo una
simbiosi particolare con essa, e che vide in questo periodo la
costituzione dei distretti pievani, territori organizzati
intorno ad una chiesa matrice. Negli angoli più riposti di
quest'area il cristianesimo delle origini non scomparve,
nonostante il fallimento del mondo romano e gli sconvolgimenti
delle invasioni. Fu in questi ambienti che andò formandosi, come
in tutte le comunità postcristiane, quel sincretismo di
cristianesimo e paganesimo che è substrato della religiosità
popolare, in cui i comportamenti pagani, depurati dall’aspetto
religioso, si trasformarono in atti consuetudinari permettendo
al cristianesimo di assorbirli in sé. Ciò avvenne per il culto
dei santi e degli angeli che sostituì il bisogno pagano di
quella serie di dei minori che accompagnavano l’uomo dalla
nascita alla morte e portò alla pratica di porre croci o piccole
cappelle nei luoghi della vita quotidiana, campi o case, per
rimanere sotto la protezione divina. Questo spiega il perché di
tante chiese forinesi dislocate all’esterno dei centri abitati o
in aperta campagna. Intanto, all’orizzonte nuove guerre
allungavano le loro tenebrose ombre sull’Italia. Nell’anno 568
fecero la loro apparizione sul suolo italiano i Longobardi, che
scesero fino al meridione, occupando con le armi alcuni
territori del napoletano e fondando nel 570 il Ducato di
Benevento. Anche Forino passò sotto la dominazione longobarda ed
ebbe a capo uno sculdascio. Ancora anni bui per Forino? Non
sembra: gli “invasori” Longobardi non dovettero essere
particolarmente feroci, anche se la storia ci ha tramandato
episodi a loro attribuiti tali da far inorridire gli animi.
Nonostante tutto, il culto di San Nicola non fu abbandonato,
anche se erano stati veramente pochi gli anni intercorsi tra la
riconquista bizantina e l’invasione longobarda perché si potesse
talmente radicare nel territorio il culto del vescovo di Myra.
Anzi, a tal proposito, e conoscendo le tradizioni locali, viene
da pensare che due comunità in quei tempi ben distinte,
riuscissero a coesistere nella vallata forinese. Magari, anzi,
sicuramente con il tempo le comunità si saranno frammiste grazie
ai matrimoni, ma se riescono a coesistere due culti così remoti,
come quello di San Nicola introdotto dai Bizantini e quello di
San Michele Arcangelo, protettore delle genti longobarde, si
evince che nonostante tutto le popolazioni non furono tra di
loro particolarmente bellicose. A sostegno di queste ipotesi
vanno due fatti: il primo lo fornisce la storia del Tornatore,
che riporta una notizia 586, circa una contesa sorta, il giudice
Amato interrogò “etiam Sacerdotem ac Recorem Ecclesiae S.
Nicolai propre Furino”. Questa è la prima menzione circa
l’esistenza di una chiesa titolata al Vescovo di Myra. E quindi
stiamo parlando di 34 anni dalla sconfitta dei Goti e dal
ritorno dei Bizantini, e di soli 16 anni dalla costituzione del
Ducato di Benevento. Inoltre, secondo fatto, va ricordato
l’accordo del 598, con il quale al Papa Gregorio I viene
facilitata l’opera di conversione al cristianesimo cattolico
delle genti longobarde. Questo stato di cose non rassegnò i
Bizantini a rinunciare all’Italia e, dopo qualche decennio
(662), Costante II tentò di rimpossessarsi dei territori
peninsulari. L'arrivo di Costante in Italia suscitò un’enorme
sorpresa perché era dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente
che un Imperatore romano non risiedeva in Italia. Nel 663,
sbarcato a Taranto, condusse l'ultima vera e decisa azione
dell'Impero Romano d'Oriente diretta a riconquistare i territori
occidentali e a riaffermare nei fatti la superiorità formale
dell'Impero. |
|
Tra realtà e leggenda, giunto a Taranto, una
delle prime cose che Costante fece fu quello di consultare
un eremita, che si diceva avesse la capacità di prevedere il
futuro. Lo interrogò sull’esito della spedizione, e
l'eremita sentenziò:
"La gente dei longobardi non può essere vinta da nessuno, perché
una regina, venuta da altri paesi, ha costruito nel loro
territorio una basilica al beato Giovanni Battista, e perciò lo
stesso beato Giovanni intercede continuamente a favore di quel
popolo. Ma verrà un tempo quando tale santuario non sarà più
tenuto in onore, e allora quella gente perirà." (Paolo Diacono,
"Historia Langobardorum, Libro V, Capitolo 6"). Il perché
di questa opportuna citazione lo comprenderemo in seguito.
Nonostante la predizione sfavorevole, Costante decise di tentare
lo stesso l'impresa. Egli strinse un'alleanza con i Franchi, che
aggredirono il regno longobardo da nord, mentre egli aggrediva
il ducato di Benevento.Il duca di Benevento Romualdo non
aveva forze sufficienti per fronteggiare l'aggressione bizantina
e richiese aiuto al padre Grimoaldo, re dei Longobardi.
Tuttavia quest'ultimo non lo poté inizialmente aiutare perché
impegnato nel respingere l'invasione franca del Nord Italia.
Costante II conquistò qualche facile successo, cosa che però
non gli riuscì con l'assediò alla città di Benevento.
Intanto Grimoaldo, sconfitti i Franchi, accorse in aiuto del
figlio. Conscio dell'arrivo di Grimoaldo, che temeva,
Costante II firmò una pace con Romualdo, pose fine
all'assedio di Benevento e decise di ripiegare verso la già
sottomessa Napoli. |

La zona compresa tra il
Monte Bufoni e il Colle San Nicola |
|
|

L'antica grotta a Faliesi |
Giunto a destinazione, Costante II,
evidentemente non rassegnato, fece un ultimo tentativo per
conquistare il ducato: “Uno dei
suoi ottimati di nome Saburro, come si narra, chiese ad
Augusto ventimila uomini e promise che avrebbe affrontato
vittoriosamente Romualdo. Ottenuto l’esercito e giunto in un
luogo chiamato Forino (ad locum cui Forinus nomen est),
vi pose l’accampamento. Grimoaldo, che era già arrivato a
Benevento, non appena lo seppe, decise di muovergli contro.
Gli disse il figlio Romualdo: ’Non c’è n’è bisogno; dateci
soltanto una parte del vostro esercito. L’affronterò io, con
l’aiuto di Dio, e quando avrò vinto sarà data maggior gloria
alla vostra potenza’.Così avvenne. Ricevuta una parte
dell’esercito del padre, insieme a suoi uomini, marciò
contro Saburro. Prima di attaccare battaglia, fece suonare
le trombe in quattro direzioni, e subito si lanciò con
audacia su di loro. Mentre i due schieramenti combattevano con
accanimento, uno dell’esercito del re, di nome Amalongo, che
di solito portava il vessillo del re issato sulla lancia,
percosse forte con quella stessa lancia, a mani unite, un
greco, lo prese dalla sella su cui cavalcava e lo sollevò
per aria sopra il suo capo. Vedendo ciò, l’esercito dei
Greci, preso all’improvviso da immenso terrore, si volse in
fuga, e fatto rovinosamente a pezzi, fuggendo procurò a sé
morte, a Romualdo e ai Longobardi vittoria. Così Saburro che
aveva promesso al suo imperatore il trofeo della vittoria
sui Longobardi, ritornando a lui con pochi uomini, gli recò
l’ignominia. Romualdo, invece, ottenuta la vittoria sui
nemici, ritornò trionfante a Benevento e procurò gioia al
padre e a tutti sicurezza, eliminando la paura del nemico”
(Paolo Diacono, "Historia Longobardorum, Libro V, 10").
La tradizione vuole sia stata combattuta l’8 di maggio. I
Longobardi, ad imperituro ricordo, pensarono bene di erigere
in nella zona uno dei numerosi santuari o chiese rupestri
dedicati a San Michele Arcangelo, inserito in quella
traiettoria che va dal Tirreno all’Adriatico. |
|
|
E' molto probabile anche che il nome al monte
Faliesi, dove è posto questo luogo di culto, sia stato dato dai
Longobardi in occasione di tale evento. Il nome è di chiara
origine germanica: l’antico alto tedesco falisa significava
‘rupe, roccia’. La posizione della grotta sul Faliesi fa
pensare che la battaglia sia stata combattuta nella zona che
segna il confine tra Forino e Contrada. La conformazione morfologica dei luoghi però
negano la possibilità che i Bizantini potessero scegliere quest'area
per il loro accampamento. Altre supposizioni optano che questo
fosse stato impiantato, e appare più plausibile, nella zona tra
la collina di Bufoni e quella di San Nicola. I Bizantini
avrebbero trovato un miglior riparo, venendo poi sorpresi dai
Longobardi che, in numero inferiore, hanno sfruttato le colline
per poter stringere ed annientare l’esercito bizantino. |
|
Uno dei motivi per cui è opportuno dare
credibilità a questa ipotesi è la presenza, in questa zona,
della Chiesa di San Giovanni De
Celsis. La chiesa si trova a ridosso del Fosso delle
Pescare, l'inghiottitoio naturale che si trova alle spalle
della frazione Celzi e che tanti problemi crea quando il
deflusso delle acque piovane non avviene regolarmente. Il
posizionamento in un'area soggetta a periodici eventi
alluvionali fornisce una lettura sulle sue caratteristiche
di costruzione. Fotografie scattate dalle rampe della strada
che conduce a Castello, ci indicano che la chiesa,
nonostante sia stata testimone nei secoli di tante
alluvioni, con conseguenti sversamenti di detriti e fango, è posta su una specie di tumulo
la cui origine è certamente artificiale, e che quindi la difende
da eventi estremi. Infatti quando l’acqua sale, la lambisce
appena e quasi mai la raggiunge. Queste considerazioni ci
inducono a raccontare di alcune strane leggende che
circolano su questo edificio le cui origini si perdono nel
tempo. I racconti fantastici dei vecchi coloni del terreno
circostante narrano dei ritrovamenti a più riprese, in
passato, di ossa umane ivi sepolte in grande quantità. Siamo
entrati nel campo delle supposizioni, e nessun studio è
stato posto in essere al riguardo, ma si potrebbe pensare
che quel tumulo se fosse di origine artificiale, e dove posa
le fondamenta la chiesetta, possa altro non essere che una
grande fossa comune dove riposano i resti di chi combattè
quella sanguinosa battaglia. A suffragio di questa ipotesi
ci viene la titolazione della chiesetta, che ci ricorda la
predizione dell'eremita a Costante II, trovando un suo
fondamento per quelle che erano le tradizioni longobarde.
Alla fine del VI secolo d.c., la regina Teodolinda volle che
venisse costruita a Monza, residenza estiva della corte
longobarda, una chiesa in onore di San Giovanni Battista.
L'erezione di questa basilica assunse un importante ruolo
simbolico e sacro nell'immaginario longobardo, tanto che
nella succitata profezia l'eremita affermò che i Longobardi
erano invincibili poiché protetti da san Giovanni, proprio
grazie alla decisione di Teodolinda di costruire quella
basilica in suo onore. Quindi i Longobardi, oltre alla
devozione per San Michele Arcangelo, ne avevano un'altra
certamente pari per San Giovanni. Questa nuova
considerazione ci suggerisce che le leggende intorno a
questa chiesetta possano avere un fondamento di verità.
Tutti questi piccoli tasselli che fanno parte di un grande mosaico, e il
fatto che a Forino coesistano ancora, dopo tanti secoli, i culti
contrapposti di popolazioni così antiche quali le Longobarde e le
Bizantine, rendono questa storia unica e affascinante. Ma credere che
queste antiche rivalità non siano sopite è quantomeno una
contraddizione. Ogni anno, di fronte la Chiesa
dell'Annunziata, nei pressi del cimitero, avviene un fatto
che è una riproposizione storica dei fatti del 663. Durante
la processione che reca il simulacro di San Nicola,
protettore di Forino, dal santuario sul colle alla chiesa di
Santo Stefano, nel momento in cui le congreghe di Petruro (i
cui abitanti, fedelissimi di San Michele, da sempre sono
depositari di caratteristiche riconducibili alle popolazioni
longobarde) prendono in consegna la statua dalle congreghe
forinesi, il "votta votta" che si crea, che a volte è
qualcosa di più di uno semplice spintone, ripropone
all'osservatore una sorta di "scontro" fisico che ricorda
gli antagonismi tra Bizantini e Longobardi. |
|

La Chiesa di San
Giovanni de Celsis |
|
 |
|

Il "votta votta" davanti la
Chiesa dell'Annunziata |
|
|
|
(tutti i diritti sono riservati, in caso di utilizzo OBBLIGATORIO
citarne la fonte) |
|
|
|